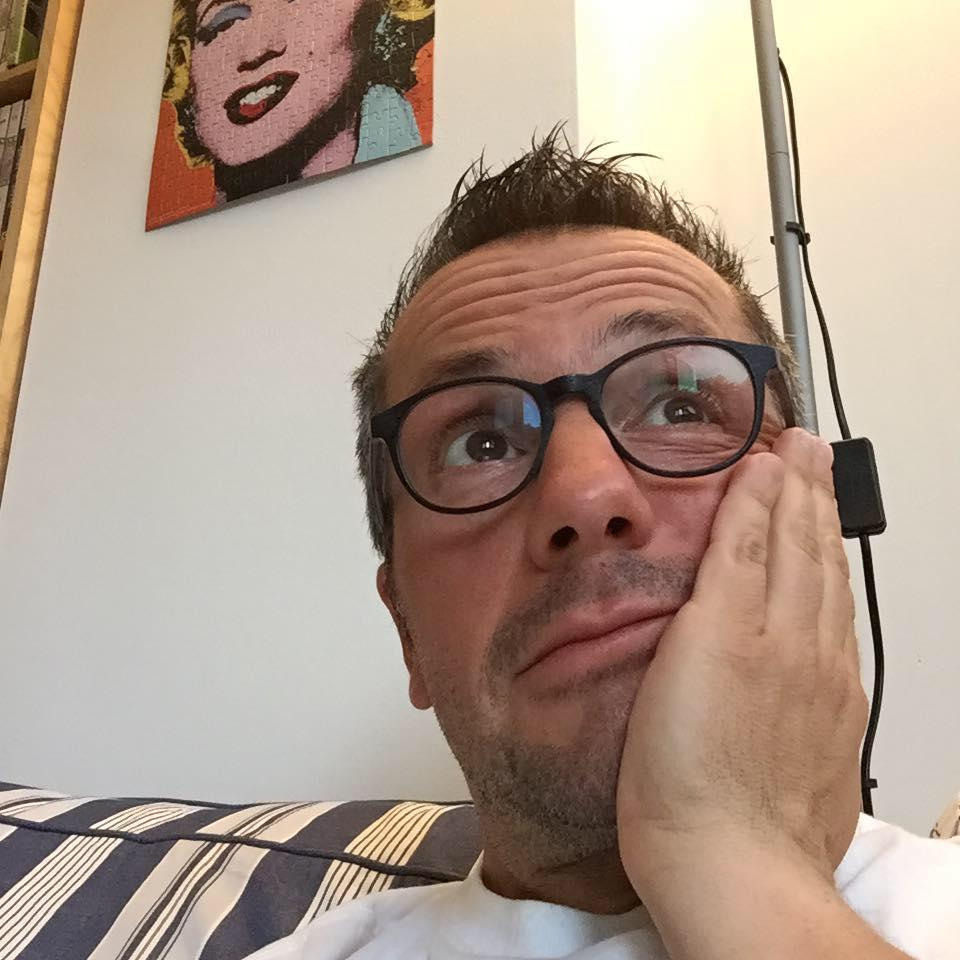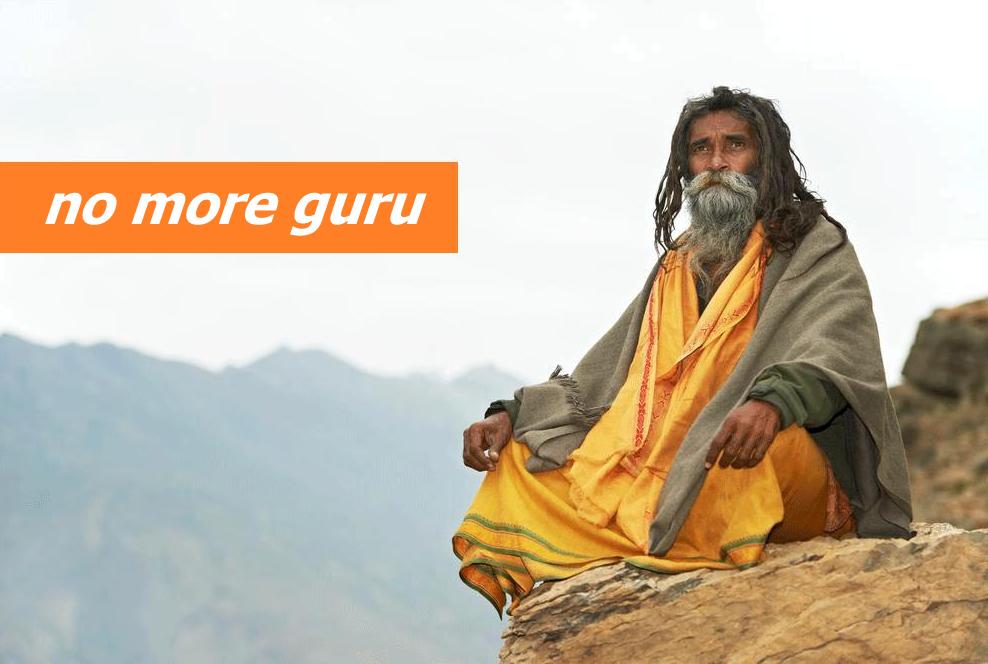Tag: risorse umane
-

Come suonare la chitarra
Non so se tra di voi che leggete c’è qualcuno che ha imparato a suonare la chitarra. Il sottoscritto l’ha sempre inserita tra le attività da mettere in cantiere alla voce “hobby e passioni” dopo averla tenuta per tempo nella sezione “crucci di cose che non hai fatto quando eri più giovane”. Ad ogni modo sempre…
-

Perché lo fai?
Vi è mai capitato di realizzare un’impresa? Non intendo l’”attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (anche se poi ci sarà un motivo per cui si chiama così). Quello che intendo è una attività che vi ha richiesto risorse ed energie oltre i vostri limiti, che vi…
-

Mi piace il lunedì
Lo devo scrivere oggi e non più tardi di oggi (anche per evitare di ricredermi domani): mi piace il lunedì! Anche se è il primo giorno della settimana e tutto sembra insormontabile, anche se è il giorno che segna la fine della festa e del relax, anche se è il giorno che ti ricorda i doveri…
-

Meraviglia!
Quante volte vi capita di stupirvi? E quante volte lo stupore è uno stimolo, un incentivo a fare cose diverse e più entusiasmanti? A me è capitato di stupirmi (ma forse sono un po’ “facile” da questo punto di vista) partecipando alle TEDxBologna 2013, una serie di talk dedicati alle innovazioni esponenziali. La mission delle…