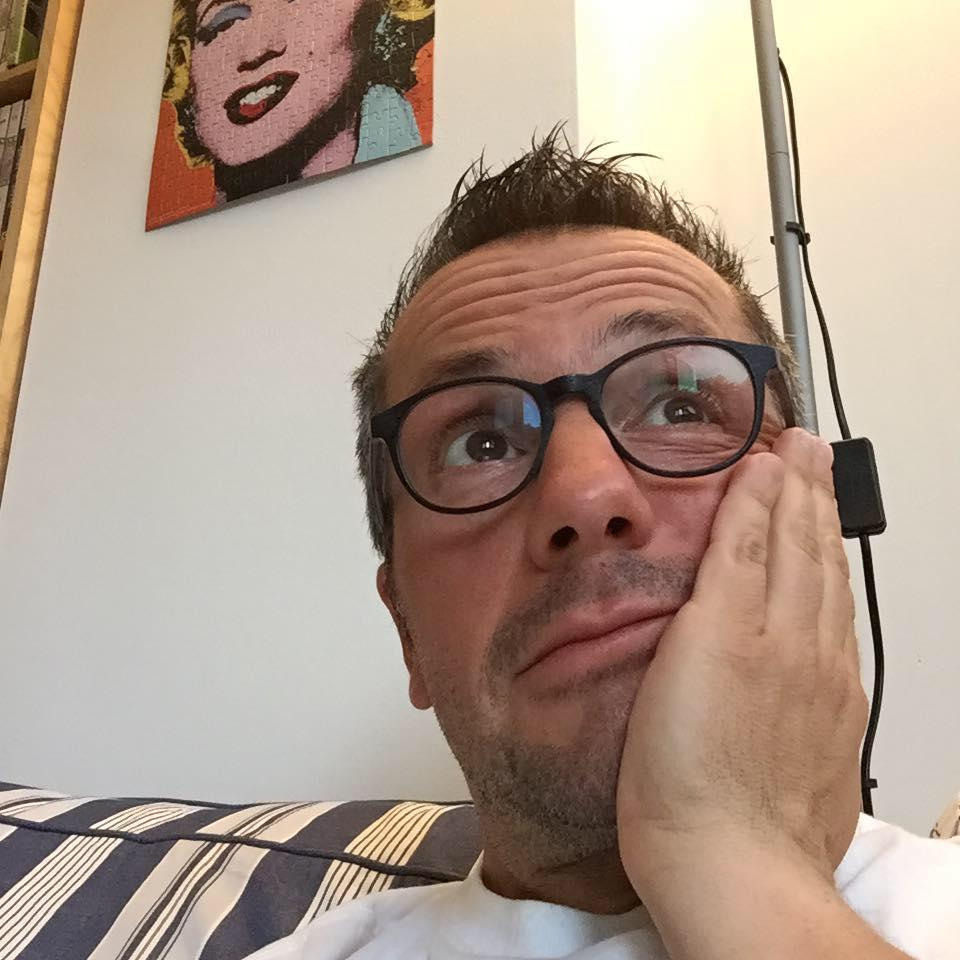Tag: professioni
-

Trovare coraggio, senza averlo
Mi chiedo spesso “chi me lo fa fare?” quando accetto sfide e opportunità che non solo mi fanno uscire dalla famigerata comfort zone ma che a volte mi mettono paura e timore di non essere in grado di cavarmela. Ma ho trovato un metodo, non risolutivo, per arrangiarmi che qui ho provato a raccontare.
-

AIDA
Per avere successo in un processo di selezione si può seguire l’AIDA. Non si tratta dell’opera lirica in quattro atti di Giuseppe Verdi, ma dell’acronimo proposta da Bernd Faas in alcuni suoi seminari di formazione sui temi del lavoro in ambito europeo. Perché oggi ormai, soprattutto per chi esce da un percorso formativo in giovane età, il terreno…